Le Isole di Sopravento
A volte la Martinica ti dà la sensazione di essere un’isola incontaminata, nonostante l’autostrada, una sola, di appena 20 km ma sempre intasata, i grandi centri commerciali i grand hotel e le zone industriali. Ma basta uscire qualche centinaio di metri dalle vie principali e ci si trova immersi in un fantastico mondo caraibico. I martinicani, al di fuori delle loro abitudini moderne, non perdono occasione per rituffarsi in un passato di tradizioni e nostalgie dal sapore africano, le feste in maschera nei quartieri di Fort-de-France, le regate con le tipiche yole dalla vela quadrata costruite da abili mastri d’ascia, i concerti di musica afro-jazz nelle piazze ed il teatro popolare all’aperto nelle vie lontane dagli occhi dei turisti. Percorrendo la RN (route nationale) che taglia l’isola da nord a sud si ha la fortuna di passare attraverso alcune aree montuose ancora coperte da porzioni di foresta pluviale che danno la sensazione di attraversare l’era dei dinosauri. Felci che normalmente in casa nostra si seccano prima di raggiungere i 50 cm, qui arrivano a 10 mt. di altezza e oltre, aprendo ombrelli di foglie degne delle palme più belle. Gli enormi granchi gialli d’acqua dolce, le migale (tarantole) iridescenti, i rettili, i colibrì e le orchidee affascinano a tal punto che non innamorarsi di Martinica è quasi impossibile. Un luogo tranquillo, ospitale e abbastanza sicuro, a differenza di molte altre isole vicine. Qui la gastronomia raggiunge standard qualitativi di grande livello grazie alle materie prime di ottima qualità, la grande varietà di spezie e, non ultima, l’influenza di varie etnie che susseguitesi nei secoli ne hanno arricchito la cultura.
Prima di salpare da Le Marin ci tocca la parte burocratica. Passiamo all’ufficio del porto che funge da capitaneria, dogana e immigrazione dove i funzionari con grande pazienza e gentilezza ci aiutano a riempire qualche modulo. Presentiamo la crew list, due timbri una ricevuta e siamo pronti per issare le vele. Spinti dagli Alisei, che qui soffiano costanti da ottobre a maggio, puntiamo verso sud col nostro catamarano, un Bahia 46, diretti a Saint Lucia che raggiungeremo dopo circa 6 ore di navigazione. Nonostante la bella stagione oggi è una giornata di maltempo con vento molto forte al giardinetto e onde imponenti che rendono faticosa la traversata del canale tra le due isole. Sono solo 30 miglia ma sufficienti per farci arrivare stanchi e bagnati. Saltiamo Rodney Bay, porto turistico a nord dell’isola, saltiamo Castries, la capitale, e con un piccolo sforzo in più entriamo finalmente nella fascinosa Marigot Bay. Dal mare quasi non si vede. Solo una spaccatura nella costa mimetizzata nella vegetazione, l’unico segno di riconoscimento visibile da lontano è una casa col tetto rosso in cima alla scogliera. Una volta avvicinati all’ingresso della baia lo spettacolo è unico. Un canale di avvicinamento stretto e profondo che termina contro un lingua di sabbia con delle palme, un piccolo spazio per entrare e al di là … una laguna di mangrovie meravigliosa. Solo un piccolo passaggio sulla destra con fondo basso permette alle barche con poco pescaggio di rifugiarsi in quello che da queste parti è considerato un Hurricane Hole, ossia un posto dove in caso di uragani si ha qualche possibilità di salvare la barca. All’interno l’acqua è scura e melmosa. C’è pochissimo ricambio con il mare aperto e il fango dove crescono le mangrovie rende l’acqua di un colore cupo e minaccioso ma di immenso fascino. Le alte pareti circostanti, i colori scuri della fitta vegetazione e la quiete “lacustre” fanno di questo “buco” un luogo adatto ai naviganti più che ai turisti convenzionali. Molte barche sono qui alla fonda. Mi presento all’ufficio per sbrigare le pratiche di ingresso nel paese: capitaneria, dogana e immigrazione. Dichiaro che uscirò tra due giorni e quindi faccio pratiche di ingresso e uscita in una sola volta, pagando una piccola tassa in moneta locale, gli E.C. (Eastern Caribbean Dollar). Anche qui sono gentili e veloci, riprendo il dinghy e torno a bordo. La notte passa nella tranquillità più assoluta.
Non è ancora l’alba quando salpo l’ancora. Tutti dormono ancora, cerco di fare meno rumore possibile sia per non disturbare sia perché voglio godermi questo momento tutto da solo. Scivolando furtivo sull’acqua ferma ripercorro il canale a ritroso ed esco in mare aperto. Con la sola vela di prua e la lenza per la pesca alla traina a poppa, costeggio quest’isola meravigliosa e verdissima dirigendomi verso i Pitons. Superata la cittadina di Soufriérè, un posto ideale dove girare un film di pirati ma purtroppo avvolta da uno sgradevole odore di zolfo che rivela la presenza del vulcano, ci troviamo sotto i Pitons: due picchi appuntiti, le cui pareti incredibilmente verticali s’innalzano dall’acqua fino a raggiungere 900mt l’uno e 750 mt l’altro. Ci troviamo nel mezzo una baia molto esposta dove tutto è protetto, non si può dare àncora ma è possibile prendere un gavitello dietro pagamento di una piccola tassa per il parco marino: l’ideale per una breve sosta e un bagno nell’acqua fredda e cristallina prima di intraprendere un’altra traversata di 35 miglia, il canale tra Sant Lucia e Saint Vincent, e andare a passare la notte a Cumberland Bay, situata circa a metà dell’isola di Saint Vincent.
 Queste sono isole vulcaniche e le baie più protette sono spesso quel che resta di un cratere collassato in mare, profondo. A pochi metri dalla riva contiamo ancora 30/40 mt di profondità, bisogna dare àncora con molta catena che scende quasi verticale e portare lunghe cime d’ormeggio a terra. Alcuni ragazzini ci offrono aiuto per legare le cime alle palme oltre la spiaggia. Compriamo frutta fresca e cocchi da alcuni venditori ambulanti che girano su piccole canoe a remi e finalmente ci godiamo il tramonto. L’ultimo raggio di sole illumina la costa da sotto uno spesso strato di nuvole così basse che non ci permettono di vedere la cima delle colline, fenomeno non raro sul lato sottovento alle isole più grandi. L’aria è tersa e i colori sono vivissimi: il blu, quasi nero, del mare, il verde della foresta macchiata qua e là da cuscini di fiori rossi del flamboyant, il piombo del cielo incombente. Non ci sono case sulla spiaggia, se non qualche provvisoria baracca. Il villaggio è dietro le colline, qui sono solo palme. I locali tra poco se ne andranno e la baia cadrà nel silenzio e nel buio più profondi.
Queste sono isole vulcaniche e le baie più protette sono spesso quel che resta di un cratere collassato in mare, profondo. A pochi metri dalla riva contiamo ancora 30/40 mt di profondità, bisogna dare àncora con molta catena che scende quasi verticale e portare lunghe cime d’ormeggio a terra. Alcuni ragazzini ci offrono aiuto per legare le cime alle palme oltre la spiaggia. Compriamo frutta fresca e cocchi da alcuni venditori ambulanti che girano su piccole canoe a remi e finalmente ci godiamo il tramonto. L’ultimo raggio di sole illumina la costa da sotto uno spesso strato di nuvole così basse che non ci permettono di vedere la cima delle colline, fenomeno non raro sul lato sottovento alle isole più grandi. L’aria è tersa e i colori sono vivissimi: il blu, quasi nero, del mare, il verde della foresta macchiata qua e là da cuscini di fiori rossi del flamboyant, il piombo del cielo incombente. Non ci sono case sulla spiaggia, se non qualche provvisoria baracca. Il villaggio è dietro le colline, qui sono solo palme. I locali tra poco se ne andranno e la baia cadrà nel silenzio e nel buio più profondi.
Questo trasferimento veloce ci fa saltare Kingstown, la capitale di Saint Vincent. Una bella città con un mercato suggestivo e coloratissimo e un grande porto, ma troppo pericolosa per meritare una sosta. Superiamo Young Island Cut e Blue Lagoon. Solo 8 miglia ci separano da Bequia, la prima e forse la più affascinante delle isole Grenadine, sempre facenti parte dello stato di Saint Vincent.
Sono tutti qui! Sembra che i velisti giramondo si siano dati appuntamento. E’ un’emozione. Chi naviga non può venire ai Carabi senza passare da due posti storici: Secret Harbour ad Antigua e Admiralty Bay a Bequia. Alla fonda ci sono barche a vela di ogni genere provenienti da tutto il mondo. Ho visto cileni, australiani, sudafricani e perfino barche battenti bandiera del sol levante o di Hong Kong. Nessuno vuole privarsi di una sosta con piña colada a Port Elizabeth.
Il villaggio si trova in fondo alla baia: case dai colori pastello, esplosioni fucsia di bouganville, file interminabili di magliette svolazzanti appese alle palme, anziani rasta che vendono conchiglie e, alla sera, barettini in riva all’acqua stracolmi di gente, musica e rhum.
Issiamo la bandiera gialla, qui le autorità sono molto severe per chi non si presenta agli uffici portuali anche perché viene richiesta una tassa d’ingresso al parco marino abbastanza onerosa. La bandiera, che sta per una richiesta di ricevere a bordo le autorità doganali, mi permette di aspettare fino a domani senza troppi problemi.
 A Port Elisabeth ho conosciuto Carib un simpatico rasta discendente degli indiani caribi. L’avevano appena trovato in mare aperto. Si era perso o meglio, per un’avaria al motore della sua piccola barca era stato spinto al largo dai venti di NE andando alla deriva per sei giorni in mare aperto. Si era salvato bevendo acqua di mare e mangiando qualche pesce volante. Con assoluta tranquillità mi disse che di questi incidenti ne capitano spesso. I Caribi furono l’ultima popolazione indigena ad abitare queste isole. Intorno al 1200 invasero le Isole di Sopravento partendo dalle coste dell’attuale Venezuela. Feroci e combattivi cacciarono i loro predecessori gli Arawaks, più miti e stanziali.
A Port Elisabeth ho conosciuto Carib un simpatico rasta discendente degli indiani caribi. L’avevano appena trovato in mare aperto. Si era perso o meglio, per un’avaria al motore della sua piccola barca era stato spinto al largo dai venti di NE andando alla deriva per sei giorni in mare aperto. Si era salvato bevendo acqua di mare e mangiando qualche pesce volante. Con assoluta tranquillità mi disse che di questi incidenti ne capitano spesso. I Caribi furono l’ultima popolazione indigena ad abitare queste isole. Intorno al 1200 invasero le Isole di Sopravento partendo dalle coste dell’attuale Venezuela. Feroci e combattivi cacciarono i loro predecessori gli Arawaks, più miti e stanziali.
Un tempo di pelle chiara e zigomi alti e occhi vagamente orientali i Caribi, in anni di convivenza con la razza africana, hanno oggi perso quei tratti somatici che li caratterizzavano. Difficilmente distinguibili dal resto della popolazione, vivono un po’ su tutte le isole delle Piccole Antille. Per almeno 400 anni cacciarono e furono cacciati, diedero del filo da torcere ai colonizzatori Inglesi e Spagnoli, accettarono di buon grado alcuni schiavi africani naufragati e dispersi sulle isole, a volte ne fecero degli alleati per piccole lotte locali. Fino al triste epilogo della loro storia. A Grenada i Caribi rimasti compirono un atto clamoroso. Prima che l’isola passasse in mano inglese, i Francesi tentarono di sottomettere definitivamente gli ultimi indios, ma i Caribi piuttosto che cedere preferirono suicidarsi in massa buttandosi in mare. Uomini, donne e bambini saltarono da una rupe situata a nord dell’isola, località ancora oggi denominata Sauteurs da quell’infausto evento.
A parte qualche individuo, come dicevo, sparso qua e là sulle isole, una colonia di circa 3000 Caribi vive ancora oggi su Dominica, nella riserva indiana chiamata “The Caribs Territory”. I Caribi ebbero i primi “contatti” con altre etnie quando un vascello olandese carico di schiavi fece naufragio proprio qui, attraversando il canale tra Saint Vincent e Bequia. I Caribi, per l’odio che portavano verso gli europei, accettarono che i neri africani si unissero a loro dando così inizio ad una nuova razza i black-carib.
Saltiamo Moustique e Canuan, isole belle ma per il nostro tipo di viaggio troppo pretenziose e snob: solo campi da golf, ville e resort esclusivi.
Entriamo allora nel cuore delle Grenadine: Mayreau, Tobago Keys, Union, Petit Saint Vincent e Palm Island, piccole isole di straordinaria bellezza che emergono dal mare con bassi fondali corallini, tutte vicine l’una all’altra. Qui le barche a vela si contendono gli ormeggi nelle baie più protette e tranquille. I rasta a bordo di piccoli e veloci motoscafi fatti in casa offrono notte e giorno i loro servizi: pesce fresco, ghiaccio, pane, souvenirs e grigliate di aragoste sulle spiagge, alcuni di loro al calar del sole rientrano a Union, l’isola più attiva e popolata di questo piccolo arcipelago. Ed è proprio a Union che scopriamo degli spaccati di vita caraibica solitamente molto lontani dagli occhi del turista.
In un locale piuttosto famoso nella zona, ‘Lamby’, un gruppo di percussionisti ci incantano con un’esecuzione alle steel drums di tutto il miglior repertorio reggae. Divenuto amico di uno di loro, tirando mattina con qualche birra, un giovane musicista ci porterà l’indomani a conoscere un costruttore di steel drums. All’ombra di un’acacia, un personaggio, un vecchio dall’aspetto curioso e affascinante, in tuta da meccanico e cuffia antirumore, passa il tempo a martellare barili di petrolio vuoti trasformandoli in una sorta di xilofono dalle delicate sonorità. Essendo l’isola piccola e totalmente priva di attività industriali, bisogna fare arrivare i barili da fuori. Di solito arrivano dalla vicina Grenada, mi spiega. Una volta a Union vengono tagliati, levigati e con un’accurata ‘martellatura’ trasformati in veri e propri strumenti musicali per poi essere rispediti a Trinidad dove altri tecnici/musicisti si occupano dell’accordatura e dell’estetica prima di rimandarli a Union. Chi direbbe mai che un volgarissimo barile arrugginito di nessun valore e buttato in una discarica si possa trasformare, dopo tanti viaggi e tanto martellare, in uno strumento sofisticato del costo di circa 2/3000 dollari!
Rientrando da questo sacro appuntamento con la musica ci dirigiamo verso un lato dell’isola poco frequentato. Si arriva ad una spiaggia deserta che per il fatto di essere battuta dalle onde a dal vento la rende scomoda ed è quindi appannaggio di pochi. Ulteriore deterrente, le alte colline che la sormontano fanno sì che questo posto resti in ombra per buona parte della giornata. Qui qualcuno, lontano dagli occhi indiscreti dei turisti, si è ricavato una curiosa attività per un’isola così piccola e così apparentemente ricca. Spaccapietre: un’intera famiglia di 3 generazioni riduce grossi massi staccati dalla collina via via in sassi sempre più piccoli per ottenere materiale inerte da costruzione. Si inizia dal giovane capofamiglia che stacca da una cava grosse rocce con l’ausilio di una pesante pertica di ferro che usa a mo’ di piede di porco. Le rocce rotolate a valle sono recuperate dal fratello che le spacca in pietroni con una mazza robusta e le porta ai nonni che le riducono in sassi grossi come meloni, che passano alla moglie del capofamiglia che li spacca in sassi grossi come mele, che passano ai figli, due vispi ragazzini, che simpaticamente seduti su una montagnola formata dal loro lavoro li frantumano in pietruzze grosse come noci. Il tutto per 8 dollari a camion! Loro ridono gioviali ma la situazione è molto triste. Cerco di mitigare dei lontani sensi di colpa pensando che comunque su queste piccole isole il turismo resta l’unica risorsa. Non molti ne possono godere i frutti ma crea comunque un indotto che bene o male fa sopravvivere tutti. Dall’alto di una collina vedo le barche che si incrociano negli stretti passaggi tra un’isola e l’altra su rotte ormai segnate da tempo, ci si saluta, ed ognuno va a cercare il proprio angolo di paradiso, il vento, le vele, il mare, i colori: questa è pura gioia.

Questo articolo è stato gentilmente concesso da:
“NOTIZIARIO DELLA GUARDIA COSTIERA”









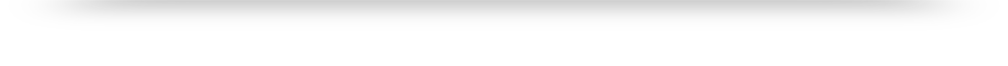
 Navigare Informati
Navigare Informati